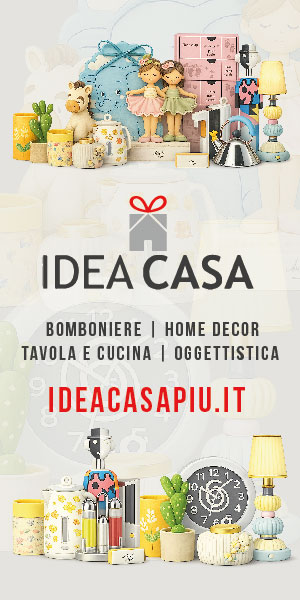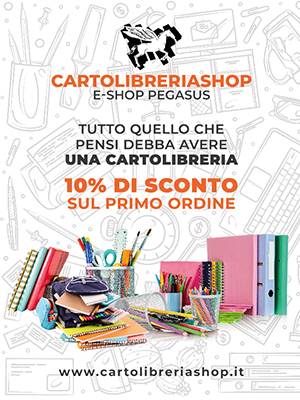Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime nuovamente la propria posizione rispetto al dibattito sorto dopo l’aggressione avvenuta a Milano, in via Vittor Pisani, dove un giovane studente di 22 anni dell’Università Bocconi è stato accoltellato da un gruppo di cinque minorenni tra i 17 e i 18 anni.
Un episodio che scuote l’opinione pubblica
«È naturale che notizie così gravi provochino smarrimento e indignazione, ma proprio per questo è necessario che la reazione pubblica non si fermi all’allarme né si trasformi in un giudizio definitivo sulla condizione giovanile. Parlare di una generazione “senza futuro” rischia infatti di diventare una profezia che si autoavvera», sottolinea il CNDDU, invitando a riflettere sui nodi culturali, sociali ed emotivi che attraversano l’adolescenza contemporanea.
Le cause del disagio giovanile
Il disagio giovanile «cresce dentro una società che negli ultimi decenni ha smarrito molti dei suoi punti di riferimento educativi. Le famiglie, sempre più sotto pressione e spesso prive di sostegni adeguati, si ritrovano a gestire fragilità relazionali ed emotive in un contesto che non ammette pause».
Anche la scuola, pur carica di aspettative, opera con risorse limitate, mentre il tessuto comunitario tradizionale si indebolisce, riducendo le opportunità di crescita dei ragazzi come membri di una collettività.
Identità, social e violenza
«Molti adolescenti vivono una crisi identitaria accentuata dall’esposizione costante agli sguardi e ai giudizi dei coetanei attraverso i social, dove la costruzione del sé è spesso frammentata e dipendente da dinamiche di visibilità. In questo scenario, la rabbia o la violenza possono diventare tentativi disfunzionali di affermare un’identità percepita come fragile o minacciata».
Il CNDDU evidenzia anche «una crescente difficoltà a riconoscere, nominare e regolare le emozioni. Molti ragazzi si ritrovano a vivere un analfabetismo emotivo di cui non sono responsabili, ma che li espone a reazioni impulsive e alla fatica di chiedere aiuto».
Il ruolo della severità e dell’educazione
«Invocare la severità può avere senso solo se accompagnata da un progetto educativo che restituisca direzione e fiducia. La sanzione non può essere concepita come punizione, ma come occasione di responsabilizzazione; altrimenti, si limita a rafforzare la distanza tra adulti e giovani».
Il CNDDU ribadisce l’importanza di un lavoro culturale che riavvicini le generazioni, mettendo al centro valori come cura, limite, reciprocità e responsabilità. «La severità va unita alla speranza, non alla disperazione».
Il ruolo della scuola e della comunità
«La scuola deve tornare a essere un luogo in cui gli studenti imparano non solo contenuti disciplinari, ma anche competenze emotive, relazionali e civiche. Servono spazi di ascolto, programmi di educazione ai diritti umani e alla nonviolenza, dialoghi aperti con le famiglie, una presenza educativa coerente e continuativa».
Valorizzare i giovani e la loro fragilità
«Non possiamo permettere che l’immagine di una generazione venga costruita soltanto dalle sue derive. I giovani non sono un problema da contenere, ma una risorsa da valorizzare. La loro fragilità parla anche delle nostre omissioni, ma soprattutto delle nostre possibilità».
L’impegno degli adulti
«Il nostro impegno, come insegnanti e come adulti, deve essere quello di restituire ai ragazzi ciò che spesso chiedono senza saperlo: una presenza autentica, un ascolto paziente, una comunità che creda nella loro capacità di crescere. Dire che “non c’è futuro” equivale a sottrarre loro ciò che è indispensabile per costruirlo. E questo, davvero, non ce lo possiamo permettere», conclude prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU.
Scopri di più da Gazzetta della Lombardia
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.